“La storia” (Elsa Morante)
“Tutto procedeva regolarmente. Ma, su una cert’ora del primo dopopranzo, mentre Bella faceva la siesta, Ida sorprese Useppe rincantucciato in terra poco più in là, addosso al muro del corridoio. Sul principio, a sogguardarlo, le parve soltanto ingrugnato; ma come gli si accostò, si accorse che piangeva, con la faccetta chiusa come un pugno, contratta e raggrinzata in tante rughe. Al guardare in su verso di lei, subitaneamente proruppe in singhiozzi asciutti. E con lo stupore di una bestiola, disse in una voce disperata:
– A mà…pecché?
In realtà, questa sua domanda non pareva rivolgersi proprio a Ida là presente: piuttosto a una qualche volontà assente, immane, e inspiegabile. Ida invece di nuovo s’immaginò che lui l’accusasse per averlo rinchiuso dentro casa a tradimento; ma presto nei seguenti giorni dovette convincersi che tale spiegazione non bastava. Quella domanda: pecché? era diventata in Useppe una sorta di ritornello, che gli tornava alle labbra fuori tempo e fuori luogo, forse per un movimento involontario (se no, si sarebbe preoccupato di pronunciarla bene con la erre). Lo si sentiva a volte ripeterla fra sé in una sequela monotona: pecché? pecché pecché pecché pecché? Ma per quanto sapesse d’automatismo, questa piccola domanda aveva un suono testardo e lacerante, piuttosto animalesco che umano. Ricordava difatti le voci dei gattini buttati via, degli asini bendati alla macina, dei caprettini caricati sul carro per la festa di Pasqua. Non si è mai saputo se tutti questi pecché innominati e senza risposta arrivino a una qualche destinazione, forse a un orecchio invulnerabile di là dai luoghi”.
(Elsa Morante, “La storia”, ed. Einaudi)
Fino a qualche settimana fa non avevo letto alcunché di Elsa Morante, poi, come scritto in un precedente articolo, ho preso “Lo scialle andaluso”, una raccolta di racconti, che mi sono piaciuti tanto da incuriosirmi circa i romanzi dell’autrice. Su questi ultimi nutrivo un pregiudizio negativo; nel mio immaginario, fondato su elementi pressoché inesistenti, la Morante aveva scritto dei “mattoni” non dico illeggibili, perché comunque mi era nota la sua fama e la sua statura letteraria, ma certo difficili da digerire. Un’elementare osservazione dei comportamenti umani ci spiega come l’aspettativa condizioni l’evento, e in particolare come si possa restare delusi quando ci si aspetta “troppo” da qualcosa e, al contrario, come si possa restare piacevolmente sorpresi quando l’aspettativa non era molto alta. Nel mio caso, “La storia” è stata una gran bella scoperta.
Il romanzo fu edito nel 1974, frutto di diversi anni di lavoro della scrittrice e all’epoca fu molto discusso, perché al grande riscontro di pubblico fece da contraltare la critica, che in alcuni suoi esponenti accusò la Morante di speculare sul dolore e di mostrare un romanzo pessimista, un atto d’accusa generalizzato, che non lasciava grandi speranze. Io, che all’epoca non ero ancora nato e che di quelle polemiche ho solo letto oggi, a posteriori, non posso che prenderne atto, metterle da parte e stabilire, molto più prosaicamente, se il romanzo è riuscito a coinvolgermi, a piacermi. La risposta è sì. Cesare Garboli, nell’ottima introduzione presente nell’edizione Einaudi, oltre a fare un bilancio a distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione, svela che lui, nel corso della rilettura, ebbe modo di cogliere lo humour che attraversava l’intera narrazione, sia pure, nel suo complesso, drammatica; la prima volta, asserisce, lo aveva interpretato “solo” come un romanzo di rabbia, ideologico, politico. Io, che leggo e scrivo a distanza di quarant’anni, e dunque non condizionato da vicende a me contemporanee (se non per via indiretta), ho colto subito lo spirito umoristico della Morante, e lo affermo perché ho letto le prime cinquecento pagine del romanzo quasi tutte d’un fiato, senza avvertire il peso di una vicenda pure tragica come quella raccontata nel romanzo. Solo nelle ultime 100-150 pagine ho avvertito un rallentamento del ritmo della narrazione, ma più che altro per una lunga “sparata” filosofico – politica che l’autrice fa per bocca di uno dei protagonisti.
In apertura di romanzo c’è una frase, in spagnolo: “Por el analfabeto a quien scribo”. In chiusura, invece, c’è “…e la Storia continua”. A me pare che queste due frasi dicano molto del romanzo. La prima ci fa comprendere che la Morante, in questo romanzo, ci rappresenterà l’esistenza di protagonisti che probabilmente non avrebbero letto il libro neanche se avessero potuto, sia perché, magari, ignari dell’esistenza dello stesso, sia perché non desiderosi di rivedersi nelle drammatiche vicende narrate. La seconda, che si lega alla prima, ci dice che la Storia, questa parola così alta ma anche così vaga, continua imperterrita ad andare avanti, mietendo le sue vittime, consapevoli o inconsapevoli, innocenti o assassine che siano. Tutti i protagonisti di “La storia” muoiono e mi si perdoni se l’ho svelato, ma del resto il lettore si accorgerà subito che non potrebbe essere altrimenti. Il romanzo è ambientato negli anni che vanno dal 1941 al 1947, con antefatti ed eventi successivi a fare da corollario. Ci troviamo, quindi, in piena seconda guerra mondiale e questo già di per sé ci fa comprendere perché la Storia non risparmi nessuno e quale sia la sorte dei protagonisti. La Morante sceglie Roma, i quartieri di San Lorenzo e Pietralata, più altri, per raccontarci la storia di Ida Ramundo, maestra elementare, che vive a Roma con il figlio Nino, un teppistello influenzato dal fascino perverso del fascismo. Ida è stuprata da un soldato tedesco e resta incinta, partorendo Giuseppe, anzi Useppe (così il piccolo storpierà il suo nome). La donna è di origine ebrea e oltre a nascondere al mondo questa sua posizione, per terrore delle leggi razziali, nasconde e protegge anche Useppe, almeno finché può.
Gli anni passano, Nino cambia sponda e diventa partigiano, ma resta sempre sfuggente, sua madre non sa quasi mai dove egli si trovi, e oscuri presagi incombono sulla sua sorte. Ida e Useppe, invece, cominciano la loro discesa negli inferi, prima in una casa comune a Pietralata, in mezzo a tanti altri disperati che la Storia spazzerà via, ma che la Morante ci fa conoscere nelle loro particolarità, nei loro vezzi, nella loro bellezza feroce, anche nella loro cattiveria reciproca. La fame, la minaccia delle rappresaglie tedesche quando la guerra ha preso una certa direzione e gli ex- alleati nell’orrore sono diventati nemici che dominano sul territorio italiano, il miraggio di una liberazione dal nazi-fascismo che tarda ad arrivare, le lacerazioni derivanti dai distacchi forzati, dalle deportazioni, questi sono alcuni degli aspetti che il romanzo tratta. Com’è intuibile, l’argomento è drammatico e il rischio di essere retorici c’è. La Morante, almeno a me è parso così, riesce a farci sentire tutto il peso della tragedia, eppure, al tempo stesso, a “divertirci”, e lo fa ricorrendo a quello humour, sia pure nero, di cui sopra. Ci sono poi, anch’essi inevitabilmente destinati a morire, molti animali nel libro: gatti, cani, pappagalli, criceti. La loro funzione è anche quella di alleggerire la narrazione, di offrire una sponda all’autrice e anche a noi lettori. Il romanzo è inoltre pieno di sogni e visioni, e in quei passaggi la Morante è particolarmente efficace nel mostrarci i deliri, talvolta comici ma spesso tragici, dei protagonisti.
“La storia” è e resta un romanzo, con tutte le grandezze e i limiti di un romanzo. Noi sappiamo che Ida e Useppe non sono realmente esistiti, sappiamo che le singole scene descritte possono essere false, ma ciò non deve farci dimenticare che per una Ida e un Useppe inventati, ce ne sono stati milioni veri, reali, travolti dalla Storia, ma direi, più amaramente, travolti da altri uomini. In un passaggio intermedio del romanzo c’è una frase, che mi ha colpito e oltre la quale non riesco ad andare. Un reduce dai campi di sterminio afferma che, in quel luogo, la camera a gas era divenuto l’unico luogo di carità, perché poneva fine a un orrore non più sostenibile. La letteratura e i romanzi forse non salveranno mai l’umanità e non credo, personalmente, che questo debba essere la missione di un romanziere. Ciò non toglie, tuttavia, che se anche un solo uomo, leggendo un romanzo, possa ricordarsi che l’orrore c’è anche in lui, e possa dominarlo, vincerlo, commuoversi per un Useppe che non è mai esistito e che pure è esistito, ecco, allora se accadrà questo, allora quell’uomo potrò comunque sentirsi meno misero.

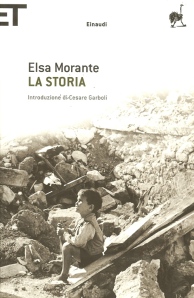
Purtroppo non l’ho ancora letto questo “grande” libro, ma la tua recensione è veramente intensa e toccante, esposta con sincerità e chiarezza. Complimenti.
Grazie. 🙂
Bellissima recensione, per un romanzo a cui voglio un gran bene. Nonostante l’ironia nera nerissima di Elsa per me rimane uno dei romanzi più dolorosi che abbia letto, ogni volta ripenso a Useppe che immagina gli “Useppolini” e mi sale il magone.
Sono d’accordo, è un romanzo doloroso nonostante, o proprio perché c’è l’ironia nera.
Questo libro l’ho sempre considerata un “must” da leggere. Non so perché ma ho sempre avuto una buona impressione fin da quando ero piccolo. Sarebbe ora che lo comprassi e lo leggessi.
Che dire… sarò banale, ma non avrei saputo descrivere meglio questo testo. E a ben vedere, probabilmente “La storia” ha avuto un ruolo più “pesante” di quanto io stessa possa pensare nella scelta dei miei studi… anche del mio modo di pensare. Grazie per tutto quello che hai scritto 🙂
Anch’io non so che dire, se non un grazie a te per i complimenti. 🙂
Tranquillo… è già abbastanza essere contenta per averti consigliato bene 😀
😀 Molto bene.
Lessi questo romanzo diversi anni fa, quando ero adolescente. Ricordo che la Morante mi piaceva tanto e per un periodo avevo letto solo lei, tutto ciò che potevo trovare in biblioteca e permettermi di acquistare.
Amai tantissimo “La Storia”, e credo di esserne stata emotivamente travolta come i suoi personaggi. Era come una poesia troppo “forte” sin dalla prima pagina, sin da quel soldato che girovaga per Roma deserta in un’atmosfera quasi sospesa perché non si sa cosa stia accadendo. Per questo motivo non sono mai riuscita a rileggerlo, nonostante l’abbia spesso desiderato.
In quel frangente l’impatto emotivo con il libro fu per me così intenso che non mi accorsi dell’ironia dell’autrice… effettivamente il tuo post me ne fa divenire consapevole. Potrebbe essere questa la spinta per rileggerlo con maggior distacco. 🙂
Grazie della tua recensione, l’ho apprezzata molto.
Grazie a te per aver condiviso qui il tuo ricordo di quella lettura e per i complimenti. 🙂