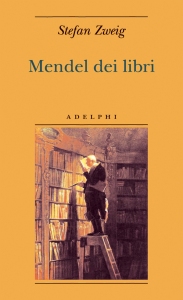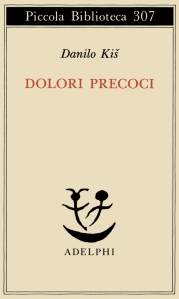“Un mondo perduto e ritrovato” (Aleksandr Lurija)
“Più a lungo la mia mente rimugina cercando nella memoria le parole necessarie per esprimere questo pensiero, più diventa difficile ricordare le parole adatte. Ma qualcosa devo pur ricordare, almeno parole approssimative, generiche, non esatte, almeno quelle. Le raccolgo, queste parole ausiliarie per il mio pensiero. Però non mi metto a scrivere subito, perché devo comporre la frase. E comincio a comporla, giro e rigiro le parole più volte, per far sì che la frase somigli a quelle che ho sentito o letto nei libri veri, corretti.
Ma che fatica scrivere! Mi viene in mente l’idea di descrivere qualcosa tratto da ciò che ricordo del ferimento, della successiva malattia, i primi tormenti. Ho preso al volo un bel pensiero! Comincio a cercare una parola per questo pensiero, poi un’altra… ma la terza parola per esprimere questo pensiero non mi viene, non la ricordo… la cerco, cerco… Alt! L’ho trovata! L’ho trovata! Ma qual era il mio pensiero?… L’ho dimenticato… E dove sono le due parole che avevo trovato con tanta fatica? Non ricordo nemmeno quelle. Torno a frugare nella memoria, di nuovo cerco il pensiero per scriverlo, cerco le parole adatte per questo o quell’altro pensiero, le annoto su fogli e foglietti, prima di inserirle nel testo che devo scrivere, unendole al pensiero sviluppato dalla mia mente disturbata dalla ferita. Ma com’è doloroso tutto questo… Dimenticare continuamente cosa stai scrivendo, cosa stai pensando, dove ti trovi, non ricordarlo, non saperlo per lunghi minuti…”
(Aleksandr Lurija, “Un mondo perduto e ritrovato”, estratto da una pagina del diario di Lev A. Zaseckij, ed. Adelphi)
Nel 1943, lungo il fronte occidentale russo, il ventitreenne soldato Lev A. Zaseckij, già studente d’ingegneria meccanica, è colpito in testa da un pallottola sparata da un tedesco, che non sarà mai estratta dal suo cervello, Continua a leggere…